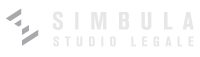I fatti sono tristemente noti:
il gestore di un sito internet italiano veniva ritenuto responsabile del concorso del reato di diffamazione commesso nell’agosto del 2009, in danno di un importante personaggio pubblico, poiché era stato pubblicato nella community del sito internet, un commento di un utente a carattere chiaramente ingiurioso e diffamatorio.
Il Tribunale di Bergamo, nel 2014, aveva assolto il gestore del sito internet, ma la procura aveva impugnato la sentenza e in sede di Appello a Brescia (giugno 2015) questi veniva condannato per concorso in diffamazione oltre al pagamento di una somma di € 60.000 per i danni asseritamene subiti dalla persona offesa dal reato.
La Cassazione ha recentemente (luglio 2016) confermato tale sentenza di appello, sostanzialmente perché la Corte d’Appello di Brescia avrebbe, in maniera “coerente e rispettosa”, correttamente ritenuto responsabile il gestore del sito, stante la sua obbiettiva conoscenza del commento diffamatorio in considerazione di una email inviata dall’utente al gestore del sito con il quale allegava un certificato penale di condanna che avrebbe dimostrato la veridicità delle affermazioni dell’utente.
Corrispondenza, questa, che – seppure in via presuntiva – evidenzierebbe una conoscenza diretta del commento da parte del gestore del sito.

Essa, almeno da quanto risulta dalla lettura dell’estratto della sentenza che abbiamo avuto modo di visionare, si è essenzialmente basata sul principio secondo il quale il gestore del sito, pur non negando i fatti in contestazione, non avrebbe avuto modo di (così dice la sentenza) “accedere al sito”, poiché il gestore era all’estero.
Dalla lettura del sintetico estratto che abbiamo avuto modo di visionare, non appare quindi chiaro se la difesa del gestore del sito, faccia riferimento all’impossibilità dell’imputato di accedere alla casella di posta elettronica per visionare la corrispondenza con l’utente autore del commento diffamatorio, o se si intenda una più generale impossibilità dell’imputato di intervenire in qualunque modo sul sito (sia per visionare il commento che per eventualmente rimuoverlo).
L’accessibilità al sito da parte del gestore non sarebbe, a quanto si comprende, effettivamente rilevante ai fini della colpevolezza o meno dell’imputato poiché la sostanziale differenza tra la sentenza di primo grado del Tribunale di Bergamo e quella di secondo grado della Corte d’Appello di Brescia, si basava proprio sull’email dell’utente con l’allegato certificato penale.
Il punto quindi è che la suprema Corte di Cassazione che, si ricorda, non entra nel merito della questione ma analizza solamente la legittimità delle precedenti pronunce, parrebbe obiettivamente corretta:
se non si contesta la ricezione dell’email dell’utente e, quindi, l’intercorsa corrispondenza tra l’utente autore del commento diffamatorio e il gestore del sito in relazione ai contenuti del commento stesso, ma solo una generica impossibilità di accedere al sito, non viene meno l’elemento fondante la condanna in secondo grado.
Ora, appare curioso, ad avviso di chi scrive, il fatto che la difesa non abbia insistito nel contestare la mancata ricezione dell’email visto che, a quanto parrebbe, non si trattava neppure di una pec ma di una peo.
In effetti il fatto che una persona si trovi all’estero non implica necessariamente impossibilità di ricevere posta elettronica e, ad avviso di chi scrive, potrebbe al contrario apparire come un tentativo di giustificazione poco credibile considerato che un gestore di un sito internet importante avrà sicuramente necessità di accedere al suo sito e alla sua casella di posta elettronica o ai suoi social network in maniera continuativa.
Probabilmente una conoscenza più approfondita del fascicolo aiuterebbe a capire esattamente cosa è accaduto.
E, attenzione, ciò che è accaduto esattamente, e gli atti della difesa e dell’accusa, dovrebbero essere oggetto di attenta analisi e di pubblica diffusione (con buona pace dell’effetto Straisand) poiché in gioco c’è l’ombra della responsabilità oggettiva che potrebbe essere stata sancita in via definitiva addirittura dalla Suprema Corte.
Se infatti la condanna di secondo grado non avesse tenuto in debita considerazione il fatto che una email inviata da un utente al gestore di un sito, non fosse stata effettivamente conosciuta dal gestore del sito stesso, in considerazione, ad esempio, dell’innumerevole quantità di commenti e utenti, questo potrebbe essere estremamente pericoloso perché potrebbe cristallizzare forme di responsabilità oggettiva che potrebbero rivoluzionare il mondo delle community on line.
In futuro infatti potrebbe bastare che il gestore di un sito sia il destinatario di una comunicazione di un utente avente ad oggetto un suo commento diffamatorio su tale sito, per dimostrare la responsabilità del gestore in concorso per diffamazione.
Responsabilità che richiede quale elemento psicologico, il dolo seppure nella sua forma generica.
Tra l’altro si rischierebbe di sovvertire il principio accusatorio e invertire l’onere della prova dell’elemento psicologico poiché non è chiaro se sia stata provata non solo la ricezione dell’email dell’utente ma anche la lettura e comprensione da parte del gestore del sito.
Ora, nel caso di specie, sempre leggendo il sintetico estratto della sentenza in commento, parrebbe effettivamente che il sito da tempo pubblicasse articoli poco favorevoli alla persona offesa dal reato e questo effettivamente non deporrebbe a favore del gestore del sito.
Il punto però è estremamente importante perché se si utilizza questa sentenza come precedente per chiedere la condanna di gestori di qualunque sito per eventuali commenti apparsi nel sito stesso, a prescindere dal numero di utenti e commenti, si confermerebbe una forma di responsabilità oggettiva che imporrebbe ai gestori di eliminare i commenti o creare filtri che possano evitare potenziali condanne per diffamazione.
Ed è qui il punto: le frasi che possono danneggiare l’onore, il decoro, la reputazione di una persona fisica o giuridica sono tecnicamente tantissime e esprimibili in varie modalità. Un filtro automatizzato di questo tipo sarebbe estremamente complicato da strutturare perché o eliminerebbe qualunque commento (il che però ci riporterebbe alla soluzione della chiusura della community) oppure eliminerebbe commenti potenzialmente non dannosi e lascerebbe invece commenti lesivi.
Si veda, per esempio, il recente caso di Facebook che, sulla base di un algoritmo, ha ritenuto oscena la foto del Nettuno di Firenze, censurandola poiché esplicitamente sessuale.
Un interessante caso di imbellicità artificiale.
L’alternativa è mettere delle persone a leggere ogni commento.
Il che vorrebbe dire che un giornale come, ad esempio, La Repubblica, dovrebbe dedicare una armata di almeno (diciamo in ipotesi) 1.000 persone a leggersi ogni giorno i commenti degli articoli pubblicati su repubblica.it.
Mentre Facebook farebbe prima a chiudere.
Insomma, in gioco c’è, non tanto la libertà di pensiero, come ho letto in alcuni articoli.
No.
La libertà di pensiero con questa sentenza non ci azzecca niente, come direbbe il nostro amico Di Pietro.
Perché descrivere una persona come (ad esempio) un corrotto e un farabutto, non ha nulla a che vedere con il pensiero, ma con l’espressione d’odio ad personam, o con il vomito di offese, per essere gentili.
Non è un pensiero scrivere che uno è corrotto. E’ una accusa, lapidaria, infinita, cristallizzata forse per sempre nella rete, che nel tempo accosta un individuo e la sua famiglia a quella identità: corrotto.
Potrà essere una accusa vera o falsa, ma rimane in realtà solo una cosa: diffamazione.
Soprattutto se non si rispettano i limiti tradizionali imposti alla stampa ma che, per analogia, dovrebbero essere estesi ai gestori dei siti e, soprattutto, ai singoli commentatori o autori seriali di post che, credendosi novelli giornalisti, commentano su tutto e tutti (dal piatto di patate mangiato a cena con il cagnolino a questioni di politica estera o economica).
Di imbecilli la rete ne è ricca. Ma in fondo è perché è pieno di imbecilli in giro. E la rete, come ha giustamente osservato Umberto Eco, ha semplicemente dato voce a questi signori giustizieri e leoni da tastiera.
Ciò detto, quindi, il punto è la possibilità di ricostruire l’esatta logica della sentenza affinché i giudici in futuro comprendano chiaramente che condannare un gestore di un sito per un commento di un suo lettore, per il solo fatto che quest’ultimo ha inviato una email a tale gestore, potrebbe veramente essere l’anticamera di una responsabilità oggettiva e la fine di intere community sane che consentono a tali siti di andare avanti e fornire informazione spesso (anche se non sempre) utili a tutta la società (inclusi gli imbecilli).