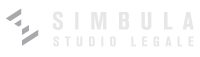Oggi 6 febbraio 2015, l’Advisory Council nominato da Google ha appena pubblicato un rapporto di circa 42 pagine nel quale si riassume l’esito delle riflessioni svolte e suggerisce al motore di ricerca alcuni principi a cui dovrebbe attenersi per accogliere o meno le richieste di disindicizzazione così come imposto dalla recente e molto discussa sentenza della Corte di Giustizia del maggio 2014.
Il rapporto, leggibile cliccando qui, è scritto da stimati professionisti che sostengono di non essere stati pagati da Google (e allora da chi?). Ma letti i loro cv, onestamente ci si aspettava qualcosa di più interessante.
A mio avviso è molto pericoloso incanalare il discorso su ciò che è etico o non è etico come si potrebbe evincere dal rapporto. Ed è altrettanto pericoloso tentare di ridurre la questione ad un problema “Google”.
L’etica non dovrebbe entrare minimamente in questo discorso poichè il punto è che una diffamazione di etico non ha niente. Una diffamazione può distruggere moralmente ed economicamente una persona. Un articolo diffamatorio perennemente disponibile in rete è una condanna, delle stigmate sociali che superano qualunque decenza e diritto all’informazione.
E anche ove delle persone si ritrovino ad apparire in un articolo giuridicamente non diffamatorio ma comunque lesivo della loro immagine (penso ad esempio a quelle persone condannate che si ritrovano la loro condanna scritta sulla rete per il resto della loro vita) devono poter avere il diritto un giorno di reinserirsi nella società senza che tutti possano costantemente ricordare il loro triste passato.
Il diritto all’oblio è concretamente tutelabile solo con la rimozione integrale dalla rete di articoli qualificati come diffamatori. L’ipocrisia dietro la quale si vuole tutelare il diritto all’informazione e sopratutto il diritto per i giornali on line di conservare una “copia” dell’articolo senza obbligo di rimozione dagli archivi interni è strabiliante.
Un archivio on line dovrebbe essere accessibile ai soli abbonati con password di accesso e non a tutti.
Altrimenti il link dove viene “archiviato” (usando la terminologia del cenozoico) l’articolo diffamatorio, potrà essere agevolmente condiviso dalla rete attraverso vari social network e sistemi di comunicazione di gruppo (skype, whatsapp). Con buna pace delle de-indicizzazioni su Google.
E poi, che senso ha de-indicizzare un link su google se poi lo stesso articolo è facilmente reperibile, su Bing, Yahoo, ecc.?
In generale gli interpreti non dovrebbero avvallare una visione “googlecentrica” del problema.
Credo che continuare a ritenere la tutela della libertà di informazione come suprema e prioritaria dinanzi a un diritto della persona così importante come il diritto alla “reputazione in rete” sia una ipocrisia assoluta che possiamo lasciare tranquillamente ai giornalisti o pseudo-giornalisti.
In un’epoca in cui gran parte della vita si svolge in rete (e direi purtroppo) questo problema sta diventando cruciale.
Che informazione è quella congerie di articoli falsi, diffamatori, semi-seri? Ripetitivi? Quale informazione è l’articolo con un titolo che dice il contrario del suo contenuto, l’articolo superficiale condiviso su Facebook con il classico aggettivo “pazzesco!”? L’articolo che insulta. E’ questa la libertà della rete?
Sono argomenti che vanno sicuramente oltre i “preziosi” suggerimenti dell’advisory board di Google (ma non pagati da Google…).
Spero che questi suggerimenti non entrino nemmeno nelle anticamere delle aule di giustizia. Perchè in modo strisciante si sta consolidando (anche grazie a questi pseudo advisory board) un’etica: l’etica dei più forti. Di quelli che possiedono tutti i nostri dati, e informazioni su usi, costumi e abitudini. E che un giorno potranno decidere sul futuro delle nostre vite.